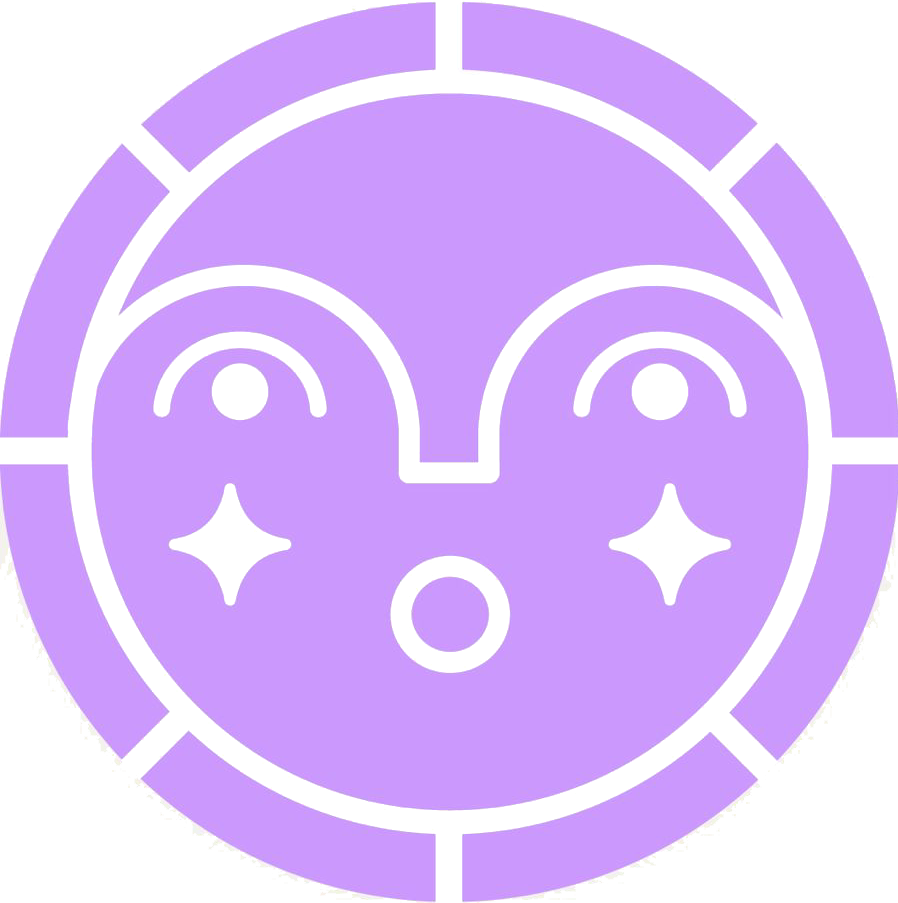Perchè scrivere un articolo sulla diagnosi?
Con questo articolo vogliamo fornire degli strumenti di base per capire la dialettica che c’è tra l’utilità che hanno le diagnosi psichiatriche e di neurodivergenza, e la necessità di mantenere un atteggiamento critico nei loro confronti. Intendiamo assumere un tono volutamente provocatorio perché il nostro intento è quello di stimolare una riflessione attiva – e anche un po’ scomoda – che metta in discussione il modo in cui ci rapportiamo al concetto stesso di diagnosi.
Siamo psicoterapeutə, più precisamente siamo psicoterapeutə cognitivo-comportamentali. Uno dei motivi per cui la terapia cognitivo-comportamentale è diventata famosa (oltre a piacere alle compagnie assicurative statunitensi per la sua brevità e le sue prove di efficacia) è che propone protocolli validati diversi per ogni disturbo. Quindi la diagnosi non è solo importante dal punto di vista epistemologico, che riguarda il modo in cui definiamo e conosciamo la sofferenza mentale, ma anche economico e politico. Chi scrive si sta specializzando in Psicoterapia Cognitiva-Comportamentale, e il processo diagnostico è una parte centrale della nostra formazione, nonché una lente attraverso cui impariamo a leggere e intervenire sulla sofferenza psicologica.
Il primo Manuale Diagnostico Statistico dei Disturbi Mentali (DSM) viene pubblicato nel 1952, ma erano già 150 anni circa che era stata coniata la parola “psichiatria”. Da allora sono uscite altre cinque edizioni del DSM, l’ultima risale all’anno scorso.
Tanto è già stato detto, quindi perché scriverci ancora? Se bastasse quello che è già stato detto non sentirei questa inquietudine: vedo diffondersi una divulgazione spesso superficiale, che tende a ridurre la diagnosi a etichette rigide, semplificando eccessivamente qualcosa che, invece, richiede attenzione e complessità.
Dalla neurodivergenza ai disturbi di personalità, la divulgazione su questi argomenti è ovunque. All’inizio ci sentivamo come San Girolamo, elettrizzate dalla possibilità che concetti complessi ed accessibili solo ad un’élite privilegiata venissero snocciolati a suon di trend, per imparare meglio e più velocemente. Con il tempo, però, le nostre espressioni si sono fatte più serie e turbate. Il nostro entusiasmo si è trasformato in preoccupazione di fronte alla superficialità con cui questi concetti venivano trattati e alla tendenza a ridurre la complessità della sofferenza psicologica a etichette rigide e semplificate.
Mosse dal bisogno di prendere una posizione su questo tema, ci rivolgiamo a chiunque voglia interrogarsi in modo critico sul ruolo della diagnosi nella salute mentale, siano essə professionistə del settore o persone che si trovano a fare i conti con questi temi per necessità o interesse personale. Il nostro intento non è dettare verità assolute, ma aprire uno spazio di riflessione condivisa.
L’approccio psicoterapeutico e la diagnosi
La diagnosi è un insieme di sintomi che, statisticamente, si presentano insieme, creando sofferenza e compromettendo il funzionamento individuale e sociale per un certo periodo di tempo. Fino qui sembra una cosa innocua. Una definizione apparentemente neutra, eppure carica di implicazioni.
Mossa dalla passione per i cappelli introduttivi, parto dall’inizio. Non spiegherò in questa sede che cosa sono gli approcci in psicoterapia, basti sapere che il nostro si chiama cognitivo-comportamentale, è basato su prove scientifiche di efficacia ed è l’approccio più presente nelle linee guida di trattamento dei principali disturbi psichiatrici. Essendo un approccio breve e che fa ampio uso di metodi statistici per valutare la sua efficacia, piace al capitalismo, che predilige approcci misurabili, standardizzati e facilmente quantificabili, e quindi siamo famosə.
Dico questo perchè il problema è che la statistica usa i numeri, spesso un po’ come le pare, ma li usa, quindi per i nostri cervelli occidentali quello che dice la scienza non rimane un tentativo di spiegare e aiutare culturalmente situato, ma diventa ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente per dare senso ai noi stessə e allə altrə.
Non siamo più semplici osservatori della condizione umana, che utilizzano strumenti necessariamente limitati e imperfetti per leggere la realtà psicologica, ma diventiamo giudici che stabiliscono confini netti tra ciò che è “normale” e ciò che non lo è, tra ciò che è sano e ciò che è patologico, tra ciò che merita ascolto e ciò che invece va respinto o relegato nell’incredibile, nel falso, nel pericoloso. La diagnosi, pertanto, smette rapidamente di essere una semplice descrizione neutrale e si trasforma in una prescrizione morale, sociale e politica. Questa dinamica affonda le radici in una visione che ha consacrato un certo regime di verità come unico criterio legittimo, separandolo drasticamente da tutto ciò che è considerato deviante, irrazionale o perturbante. L’ideale di una ragione universale ha finito per legittimare dispositivi normativi che classificano, escludono e normalizzano. In questa logica, la diagnosi assume un ruolo centrale nel consolidare l’idea che esista una forma “giusta” di essere soggetto, relegando le altre all’anomalia, all’errore o alla patologia.
Il dispositivo diagnostico, dunque, non si limita a rilevare soggettività preesistenti, ma contribuisce attivamente a produrne. Diagnosticare, infatti, non è soltanto categorizzare: è creare identità, determinare forme di vita, generare soggettività. In altre parole, la diagnosi non è solo qualcosa che attribuiamo a una persona, ma un processo che modella la sua percezione di sé e la sua interazione con lə altrə, influenzando profondamente il modo in cui si vede e viene percepita e come essa stessa si vede.
La diagnosi non è un fatto oggettivo e neutro: porta con sé delle interpretazioni, che dipendono dalla cultura, dalla società e dai valori del momento. Quindi, non è solo una classificazione, ma un modo in cui la persona può essere giudicata e definita, e questo può influenzare il suo modo di vivere e di percepirsi. Questo, colleghə, è un punto dal quale non si può prescindere.
Mi spiego con Foucault. Foucault fortunatamente ci ha lasciato in eredità il suo pensiero critico, invitandoci a mettere in discussione le strutture di potere, le norme sociali e le nostre stesse identità. Egli sosteneva che la psichiatria, come molte altre istituzioni sociali, funzionava da strumento di potere. Secondo lui, la psichiatria non era solo un campo medico dedicato alla cura della malattia mentale, ma un mezzo attraverso il quale la società esercitava controllo sugli individui. Diagnosticare e trattare la sofferenza mentale permetteva all’autorità medica di definire cosa fosse normale e cosa non lo fosse, quindi di disciplinare e normalizzare il comportamento umano. Foucault analizza come le pratiche psichiatriche non emergano in risposta a una verità scientifica sulla sofferenza, ma piuttosto si costituiscano in un gioco di forze, interessi e dispositivi di controllo. Il manicomio, la diagnosi, il trattamento: non sono semplicemente strumenti terapeutici, ma articolazioni di un potere che produce soggetti, assegna ruoli, delimita ciò che può essere detto e ciò che deve essere taciuto. Riflettere oggi sulla diagnosi senza confrontarsi con questa eredità teorica sarebbe un esercizio monco. Io, di dimenticarmi di Foucault, proprio non me la sento.
Citiamo (di nuovo, ci perdonerà) Alessandro Sahebi: “La privatizzazione del malessere trasforma la malattia mentale in un’anomalia esterna al ciclo economico e sociale in cui viviamo, legittimando i processi e i meccanismi che invece ne caratterizzano l’ossatura.”
Collega! non ti perdere e non prenderla sul personale. È nostro dovere sapere come la violenza contro tutto ciò che non è considerato “la norma” sia radicata nella nostra cultura, per riconoscerla e decostruirla. Chiediamo alle persone che cercano il nostro aiuto di riconoscere i modelli di pensiero che influenzano negativamente la loro vita, perché non dovremmo chiedere lo stesso a noi stessə?
Ad esempio, la cultura neoliberale promuove l’autorealizzazione attraverso la massima autonomia. In questo contesto, l’individualizzazione dei bisogni e dei desideri spinge la competizione nel lavoro e nella vita privata, mentre le disuguaglianze sociali sono spiegate come un risultato delle differenze individuali. O ancora, la nostra società è permeata da una cultura coloniale, ciò implica riconoscere un sistema in cui l’obiettivo è quello di stabilire e perpetuare un modello bianco e occidentale di egemonia culturale, politica, economica e linguistica attraverso il dominio e lo sfruttamento di corpi, popoli e risorse.
Martín-Baró, psicologo sociale e sacerdote gesuita salvadoregno, ha elaborato una psicologia degli oppressi come risposta critica alla psicologia occidentale, denunciando il modo in cui le pratiche cliniche e accademiche spesso perpetuano le strutture di dominio. Secondo lui, la psicologia deve partire non dall’individuo isolato, ma dalle condizioni storiche e collettive dell’oppressione, e assumere un ruolo attivamente trasformativo. Le persone che appartengono a gruppi emarginati o oppressi affrontano sfide uniche che possono influire sulla loro salute mentale. La diagnosi, nella prospettiva di Martín-Baró, è spesso funzionale alla conservazione dell’ordine sociale esistente, etichettando come disturbo ciò che può essere una risposta sana alla disumanizzazione. Egli insiste sulla necessità di de-ideologizzare la psicologia: togliere il velo di neutralità per mostrarne la complicità con l’oppressione. Riconoscere queste dinamiche è fondamentale per fornire un supporto realmente efficace e liberante (o “empowered”). Parla dell’importanza e della necessità di una scienza sociale impegnata nella liberazione, capace di rispondere alle ferite collettive degli abusi dei popoli occidentali, della guerra, della povertà, del colonialismo, e non solo ai sintomi individuali.
Noi crediamo che le persone abbiano il diritto di conoscere il nome del loro insieme di sintomi. La diagnosi, pur non essendo un punto di arrivo, offre un vocabolario condiviso per descrivere le proprie esperienze e accedere al supporto adeguato. È un punto di partenza, uno strumento per iniziare il percorso terapeutico. Tuttavia, è essenziale affrontare il tema della diagnosi con una prospettiva critica e consapevole.
La diagnosi deve quindi tenere conto sia dei sintomi individuali, sia delle condizioni sociali e sistemiche che contribuiscono al disagio. Solo così possiamo aiutare le persone non solo a gestire i sintomi, ma anche a comprendere e sfidare le radici delle loro sofferenze. La cura è cura solo se dall’individuo si espande alla collettività e la trasforma, altrimenti è una pezza. Si ha il diritto di conoscere quale nome la scienza statistica ha dato all’insieme dei nostri sintomi, ma non sarà solo quel nome a determinare il lavoro che faremo in terapia e il funzionamento unico di ogni persona, con le sue singolari caratteristiche neurali, i suoi valori, la sua storia, le sue relazioni, il suo contesto culturale ed economico. Lə colleghə penseranno “tutto questo rumore per dire quello che ci dicono sempre, che la diagnosi non è deterministica”. Io non sostengo che la diagnosi non sia deterministica io nego la diagnosi come paradigma di cura, perché lo è dell’oppressione, e le due cose sono in contraddizione. L’oppressione è così incarnata nella nostra esperienza che immaginarci una psichiatria (e un mondo) senza di essa è impossibile. Quindi rimaniamo nella dialettica tra la negazione della diagnosi e il suo utilizzo, cosa ben diversa dall’assumere la diagnosi e cercare di disinnescarla strada facendo.